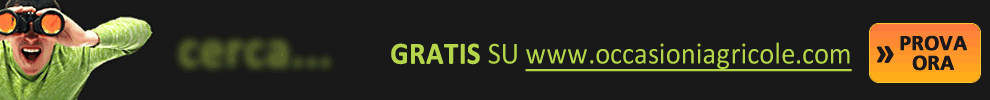Una coccinella minaccia i vigneti italiani

Risale al 2008 l’avvistamento al nord Italia del coleottero coccinellide Harmonia axyridis, meglio conosciuto come ‘coccinella arlecchino‘. Lo scorso anno questo coleottero è stato rinvenuto anche in Toscana, un segnale che fa prevedere una sua diffusione in tutta la penisola, con terribili effetti per i terreni coltivati a vigneto: questa specie di coccinella, infatti, si rifugia nei grappoli e altera il sapore del vino a causa delle sostanze che rilascia.
L’Harmonia axyridis è di origine asiatica, ma è stata utilizzata in nord America come agente di controllo biologico per afidi e coccidi a partire dal 1916. Tuttavia, fino al 1988 la diffusione di questo coleottero è sempre stata controllata e mai dannosa: è solo a partire dalla fine degli anni ottanta che la coccinella arlecchino ha cominciato a diffondersi in tutti gli Stati Uniti in maniera incontrollata, non si sa ancora se per cause accidentali o intenzionali. In ogni caso, la coccinella arlecchino ha colonizzato in fretta anche il Sudamerica, l’Egitto e il Sudafrica.
Purtroppo, prima che la sua diffusione avvenisse in modo così devastante, anche l’Europa decise di utilizzare il coleottero come agente di controllo biologico: tale scelta risale al 1964 in Ucraina, ed è stata presto imitata dalla Bielorussia (1968) e dalla Francia (1982). Anche nel vecchio continente, però, la coccinella arlecchino ha presto beffato l’uomo e ha cominciato a diffondersi nell’ambiente naturale, partendo dalla Francia nel 1991 e arrivando a colonizzare Germania, Belgio, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Italia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Ungheria, Liechtenstein, Slovenia, Ucraina, Bosnia Herzegovina, Serbia e Romania.
Nel nostro paese la diffusione della coccinella arlecchino è partita, come detto, dal nord Italia, con un percorso che dal Piemonte e dalla Lombardia ha toccato il Friuli, il Veneto, la Liguria e l’Emilia Romagna, concludendosi – almeno per ora – in Toscana.
L’esemplare adulto di Harmonia axyridis si riconosce per la lunghezza di 5-8 millimetri, maggiori rispetto a quelle delle altre coccinelle. Il suo colore invece presenta una gran varietà di toni (da questa caratteristica proviene infatti il nome comune ‘arlecchino’, nato in Gran Bretagna): il capo può essere giallo, nero o giallo con macchie nere; la parte anteriore del torace (pronoto) è gialla con macchie nere al centro; le macchie possono essere quattro, formare due linee curve, una forma di M o un trapezio; sui margini laterali si trova invece una macchia gialla di forma ovale.
Ma non è finita qui: gli esemplari di coccinella arlecchino presenti in Europa, infatti, per la tipologia di ali si distinguono ulteriormente in tre forme, ovvero la succinea, la spectabilis e la conspicua. La prima ha le ali anteriori (elitre) di colore giallo con sfumature arancioni e un numero di macchie nere variabile da zero a ventuno (talvolta fuse); le altre due invece hanno le elitre nere con macchie gialle, arancioni o rosse: tali macchie sono due per la conspicua e quattro per la spectabilis. In Italia la forma prevalente è la succinea.
Per quanto riguarda le larve di questo coleottero, esse si presentano invece con un corpo allungato, appiattito e contornato di robusti tubercoli e spine. Il colore è nero bluastro, con macchie giallo-arancioni presenti sui lobi dorsolaterali dei segmenti addominali (da una a cinque macchie per lato).
Specie polifaga che si nutre in prevalenza di afidi e cocciniglie, la Harmonia axyridis è un predatore di numerosi insetti, compresi i suoi competitori (larve di coccinella, neurotteri, ditteri sirfidi), e per questo è in grado di debellare le specie afidifaghe autoctone e sostituirsi ad esse. Solitamente la coccinella arlecchino compie due generazioni all’anno, ma può arrivare anche a cinque.
Durante il periodo di svernamento (dal tardo autunno all’inverno inoltrato) gli adulti si aggregano in siti più protetti dei vigneti, penetrando spesso negli edifici e causando ulteriori problemi all’uomo, dato che tale coleottero genera macchie sulle pareti esterne delle abitazioni e danneggia tende, arredi e vestiti all’interno dei mobili, a causa dell’emissione di emolinfa, che tra l’altro contiene anche le sostanze Hara 1 e Hara 2 che sono allergeni in grado di provocare congiuntiviti, riniti, asma e orticaria. Insomma, non sono solo gli agricoltori a odiare questa coccinella dal nome così simpatico.
– – –